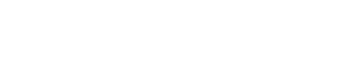REATI SOCIETARI – Governo: emendamenti con importanti proposte di modifica
Nella 2° Commissione Giustizia del Senato, la sede Referente per il Disegno di Legge riguardante. (ddl 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio) nella giornata del 7 gennaio 2015, il Governo ha presentato una serie di emendamenti
Le proposte di modifica riguardano le false comunicazioni sociali, le soglie di punibilità, le sanzioni amministrative a carico delle società in relazione alle nuove fattispecie di reato.
Il ddl n. 19, in questione, è stato oggetto da parte dell’esecutivo di Governo, di importanti proposte di modifica; vediamo, pertanto, di analizzare le principali novità apportate che , se approvate nelle forme previste dagli emendamenti governativi, in materia di falso in bilancio, sarebbero da un punto di vista penale, molto più incisive rispetto al passato.
Prima di entrare nello specifico , ricordiamo che i termini per presentare ulteriori subemendamenti agli emendamenti governativi, alla Commissione di riferimento, (Giustizia) scadono lunedì 19 gennaio 2015, ore 12.00.
Per capire al meglio la materia in questione, riportiamo un breve storico del Testo unificato dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, recante ‘Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio’
Il Testo unificato in titolo è stato adottato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta n. 111 del 14 maggio scorso.
Il Testo unificato si compone di 8 articoli organizzati in 3 Capi.
Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni in materia di corruzione e concussione.
L’articolo 1 modifica la disciplina sanzionatoria in materia di corruzione. In particolare, il comma 1, lettera a) interviene sul comma 2 dell’articolo 32-ter del codice penale, relativo all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la quale importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il vigente comma 2 dell’articolo 32-ter del codice penale prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni; la lettera citata innalza a 5 anni tale ultimo termine.
Il successivo comma 1, lettera b), intervenendo sull’articolo 32-quinquies del codice penale – che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego – stabilisce che l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, consegua alla condanna alla reclusione non inferiore ai due anni (in luogo degli attuali tre) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.
Il comma 1, lettera c) modifica l’articolo 161 del codice penale, relativo agli effetti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione, inserendo al comma 2 – nella parte in cui si prevede che l’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere – il riferimento ai delitti già menzionati: peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, di cui – rispettivamente – agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché quello ai delitti di cui agli articoli 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione) e 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) dello stesso codice.
Il comma 1, lettera d) novella l’articolo 319 del codice penale, che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, innalzando da 8 a 10 anni il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.
Il comma 1, lettera e) interviene sul comma 1 dell’articolo 319-quater del codice penale, relativo all’induzione indebita a dare o promettere utilità, innalzando il limite minimo e massimo della pena da infliggere al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena attualmente prevista dal codice penale è fissata nella reclusione da tre a otto anni, che il comma in esame propone di innalzare da quattro a dieci anni.
A seguito delle modifiche apportate dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1, per i delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e di induzione indebita a dare o promettere utilità verrebbero previsti lo stesso minimo e lo stesso massimo edittale (la reclusione da quattro a dieci anni). In proposito parrebbe doversi rammentare che, nell’ipotesi dell’induzione indebita a dare o promettere utilità – ipotesi che corrisponde, quanto alla condotta considerata, alla concussione per induzione prevista dalla formulazione dell’articolo 317 del codice penale antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 – il comportamento del pubblico ufficiale è stato tradizionalmente ritenuto più grave del comportamento del medesimo nel caso della corruzione, anche per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Infatti, nel caso della concussione per induzione e in quello della nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, il privato versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità. Il fatto che la volontà del privato non sia pienamente libera di determinarsi per effetto di questo stato di soggezione spiega perché, nel vigente assetto normativo, al soggetto che ha subito l’induzione risulti applicabile una pena relativamente contenuta (reclusione fino a tre anni).
Ma lo stato di soggezione indotto nel privato mediante l’abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio vale altresì a qualificare come avente maggiore gravità la condotta del soggetto agente rispetto a tutte le ipotesi di corruzione, determinando, nell’ipotesi dell’induzione, un ulteriore nocumento rappresentato appunto dalla lesione della libertà di autodeterminazione del privato con conseguente maggiore possibilità di danno per la pubblica amministrazione.
In questa prospettiva la previsione per il caso dell’induzione di un massimo edittale e, soprattutto, di un minimo edittale uguali a quelli previsti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio potrebbe ritenersi tale – ad una prima lettura – da presentare possibili profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, anche alla luce delle indicazioni che emergono dalla giurisprudenza costituzionale in materia(1) .
Il comma 1, lettera f) novella il comma 1 dell’articolo 323 del codice penale, che disciplina l’abuso d’ufficio, innalzando da uno a cinque anni (rispetto all’attuale previsione da uno a quattro anni) la pena della reclusione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
Il comma 1, lettera g) aggiunge un comma all’articolo 323-bis del codice penale, relativo alle circostanze attenuanti. Il comma aggiuntivo stabilisce, per i delitti previsti dai citati articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, la diminuzione della pena da un terzo alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Il nuovo secondo comma dell’articolo 323-bis del codice penale prevede pertanto un’ipotesi speciale di ravvedimento operoso disponendo – come sopra evidenziato – che per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, del medesimo codice, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.
La formulazione utilizzata nel richiamato articolo riprende, pur con alcune variazioni, quella di altre attenuanti per collaborazione previste dalle disposizioni attualmente vigenti (si vedano, a titolo esemplificativo, l’articolo 8 del decreto legge n. 152 del 1991, per i delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, ovvero l’articolo 4 del decreto legge n. 625 del 1979 per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, ovvero ancora l’articolo 600-septies.1 del codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale e l’articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione). Al riguardo potrebbe peraltro tenersi conto del fatto che – in ordine alla quasi totalità delle attenuanti per collaborazione e, comunque, in riferimento alle ipotesi di maggior rilievo – è prevista l’applicabilità di alcune disposizioni speciali che sono contenute nel decreto legge n. 8 del 1991, come modificato dalla legge n. 45 del 2001 (si vedano, in particolare, gli articoli 16-quinquies, 16-sexies e 16-septies del predetto decreto legge, nonché per correlati profili di ordinamento penitenziario il successivo articolo 16-nonies). L’ambito materiale di applicazione di tali disposizioni è individuato dall’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legge ed è costituito dai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale. A sua volta il citato comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale fa riferimento ai procedimenti per i de!
litti, c
onsumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Come emerge dalla sintetica ricostruzione del quadro normativo in questione, le richiamate disposizioni del decreto legge n. 8 del 1991 non troveranno quindi applicazione in riferimento alla nuova attenuante per collaborazione. In conseguenza di ciò, ad esempio, se l’attenuante per collaborazione di cui al nuovo secondo comma dell’articolo 323-bis del codice penale venisse concessa per effetto di dichiarazioni false o reticenti – ovvero qualora chi ha beneficiato della circostanza attenuante predetta commettesse, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio – non parrebbe possibile applicare le disposizioni speciali in tema di revisione della sentenza e di restituzione nel termine per l’impugnazione, nonché eventualmente quelle concernenti le ipotesi di calunnia, di cui all’articolo 16-septies del citato decreto legge n. 8 del 1991.
Il comma 1, lettera h) novella il comma 1 dell’articolo 346-bis del codice, che disciplina il traffico di influenze illecite, innalzando da uno a cinque anni (rispetto all’attuale previsione da uno a tre anni) la pena della reclusione per chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
L’articolo 2 modifica l’articolo 317 del codice penale in materia di concussione, estendendo all’incaricato di un pubblico servizio la pena della reclusione da sei a dodici anni prevista per il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Si rammenta che la limitazione – sotto il profilo soggettivo – dell’ambito di applicazione della fattispecie di concussione ai soli pubblici ufficiali è stata di recente introdotta dalla legge n. 190 del 2012, dopo un ampio esame parlamentare. A tale questione era stato fatto riferimento, in particolare, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, nella seduta delle Commissioni riunite I e II del 22 maggio 2012. Sul punto era intervenuto, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, il Ministro della giustizia che aveva evidenziato come la scelta di non prevedere più l’incaricato di pubblico servizio quale autore del reato trovava la propria giustificazione nella considerazione che questi non avrebbe poteri tali da essere in grado di costringere il soggetto passivo del reato, mentre è in grado di indurlo indebitamente a dare o promettere delle utilità. L’eliminazione del riferimento alla figura dell’incaricato di pubblico servizio ha ripristinato – sotto il profilo considerato – il testo dell’articolo 317 del codice penale vigente anteriormente alla riforma effettuata con la legge n. 86 del 1990. L’impostazione originaria del codice penale, infatti, non contemplava gli incaricati di pubblico servizio fra i soggetti attivi del delitto di concussione, limitando l’ambito di applicazione dello stesso ai soli pubblici ufficiali.
La novella del 1990 ritenne invece necessaria un’estensione in tal senso del predetto ambito di applicazione e modificò conseguentemente il disposto dell’articolo 317. In proposito deve ricordarsi che l’estensione dell’applicabilità della fattispecie di concussione all’incaricato di pubblico servizio era già contenuta nel disegno di legge governativo A.C. n. 2844 della IX legislatura, che essa venne riproposta nel disegno di legge A.C. n. 2441 presentato dal Governo nella X legislatura, e che confluì infine nel testo approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. n. 2078 della X legislatura) e quindi nel testo definitivamente approvato che divenne la legge n. 86 del 1990 già citata. Nel corso dell’esame parlamentare era stato rilevato come l’estensione dell’applicabilità della concussione all’incaricato di pubblico servizio fosse volta a tener conto del notevole rilievo assunto, a livello sociale, dalla figura dell’incaricato di pubblico servizio che quotidianamente entra in contatto con il cittadino utente (si veda a titolo esemplificativo il resoconto stenografico della seduta della Commissione giustizia del Senato del 15 marzo 1990). La relazione predisposta per l’esame in Assemblea (si rammenta che il testo dell’A.S. n. 2078 inizialmente assegnato in sede deliberante venne successivamente rimesso in sede referente) dava conto della definitiva scelta a favore dell’estensione in parola, che sarebbe rimasta poi nel testo divenuto legge.
Il testo in esame potrebbe ritenersi riferibile alle motivazioni e alla scelta del 1990 perché – come viene evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 19 da cui è ripresa la previsione qui considerata – non avrebbe senso punire soltanto il pubblico ufficiale,”quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario di un servizio pubblico (RAI, ENI, personale sanitario, eccetera) con effetti parimenti devastanti sull’etica dei rapporti”(2) .
L’articolo 3 introduce nel codice penale l’articolo 322-quater in materia di riparazione pecuniaria. Esso prevede che, con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter (corruzione in atti giudiziari), in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
L’articolo 4 novella la rubrica e i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 648-ter del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Nella rubrica il riferimento alla ‘provenienza illecita’ viene sostituito con quello all’impiego di denaro, beni o utilità ‘provenienti da riciclaggio'; nel comma 1 il riferimento alle utilità provenienti ‘da delitto’ viene sostituto con l’espressione ‘dal riciclaggio'; il comma 2 viene modificato nel senso di prevedere che la pena sia aumentata non ‘quando’ ma ‘se’ il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività non solo professionale, ma anche bancaria o finanziaria; il comma 4 viene novellato prevedendo l’applicabilità dell’ultimo comma dell’articolo 648 ‘in ogni caso'(3) . Il menzionato articolo 648 del codice penale nel disciplinare la ricettazione, stabilisce, all’ultimo comma, che le disposizioni in materia si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
L’articolo 5 introduce nel codice penale l’articolo 648-ter.1 in materia di autoriciclaggio. Il nuovo articolo stabilisce che chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, venga punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all’andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648 (cioè se il fatto è di particolare tenuità), e si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’articolo 648, sopra richiamato.
L’articolo 6 novella i commi 1 e 3 dell’articolo 648-quater del codice penale in materia di confisca, introducendo l’autoriciclaggio tra i delitti per i quali è sempre ordinata dal giudice la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, ovvero – in caso di impossibilità – la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
Più in generale si rileva che la formulazione vigente degli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale esclude l’applicabilità dei medesimi nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla commissione del quale derivano i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o impiego. Il fondamento di tale comune impostazione normativa è tradizionalmente ravvisato nell’assunto secondo cui l’utilizzazione dei beni di provenienza illecita, da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l’arricchimento. In altri termini il legislatore, fino ad oggi, ha configurato le condotte di cui ai predetti articoli come un autonomo reato contestabile solo a soggetti diversi dall’autore del reato presupposto, ritenendo che – ove poste in essere dall’autore del reato presupposto – la loro offensività sia già sanzionata dalla norma incriminatrice che punisce questo ultimo.
In conseguenza di ciò, ad esempio, i giudici italiani hanno respinto richieste di estradizione provenienti da paesi i cui ordinamenti consentono la contestazione di fattispecie di riciclaggio anche all’autore del reato presupposto da cui derivano i proventi riciclati, rilevando come in tali casi manchi – con specifico riferimento alle condotte di riciclaggio contestate dall’autorità giudiziaria straniera all’autore del reato – il requisito della doppia incriminazione (si vedano Cass. pen. Sez. VI n. 1732 del 1998 e Cass. pen. Sez. VI n. 31812 del 2008)(4) .
Con i nuovi articoli 648-ter e 648-ter.1 il testo in esame adotta invece una differente impostazione normativa. Infatti il nuovo articolo 648-ter continua ad applicarsi al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ma viene limitato alle sole ipotesi di impiego di denaro, beni o utilità provenienti da riciclaggio. Invece il nuovo articolo 648-ter.1 si applica a chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all’andamento dei mercati. La formulazione del nuovo articolo 648-ter.1 non esclude le ipotesi di concorso nel reato presupposto per cui la nuova fattispecie incriminatrice in questione si applicherà a chiunque impiega nei modo anzidetti i proventi di un delitto non colposo – sia che si tratti dell’autore del reato presupposto da cui i proventi derivano sia che si tratti di persona non concorrente in tale reato – a condizione però che il predetto impiego abbia determinato un nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all’andamento dei mercati.
L’articolo 7 riformula i primi tre commi dell’articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, stabilendo – al nuovo primo comma – che, fuori dai casi previsti dall’articolo 2622 del codice civile – gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori – i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione – sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Resta ferma al successivo secondo comma la previsione, già vigente, per effetto della quale la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il novellato terzo comma prevede poi l’aumento della pena fino alla metà se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società.
L’articolo 8 reca modifiche al menzionato articolo 2622 del codice civile. In particolare, i commi dal primo al quinto del vigente articolo vengono sostituiti da tre commi, in base ai quali gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante – i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione – sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà.
I successivi commi dal sesto all’ottavo del vigente articolo 2622 del codice civile sono abrogati. Il citato comma sesto, relativo all’estensione della punibilità per i fatti previsti anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, è riproposto in testo pressoché identico dal nuovo secondo comma già ricordato. Il vigente comma settimo, parimenti abrogato dalla proposta in esame, prevede l’esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. Infine il vigente comma ottavo, ugualmente abrogato dal testo unico in commento, stabilisce che in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Il nono comma dell’articolo 2622 – che nel testo vigente fa riferimento a i casi di cui ai commi settimo e ottavo dell’articolo medesimo – viene modificato sostituendo tale riferimento con quello ai casi di cui ai commi primo e terzo (sempre dello stesso articolo 2622).
Si rammenta che, nella formulazione attualmente vigente, gli articoli 2621 e 2622 del codice civile prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l’arresto fino ad un anno).
I principali elementi di novità che il testo in esame introduce nell’articolo 2621 del codice civile sono quindi i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione (da uno a cinque anni), la fattispecie viene configurata come reato di pericolo concreto; l’esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante; viene punita l’esposizione fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo (attualmente è punita solo l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni)(5) .
Analoghe considerazioni valgono per le modifiche apportate all’articolo 2622 del codice civile che, nella nuova formulazione proposta, sanziona, dal punto di vista oggettivo, una condotta analoga a quella prevista dall’articolo 2621, con la differenza che vengono previsti un più specifico ambito applicazione – circoscritto in particolare alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante – e più elevate pene edittali (la reclusione da due a otto anni).
La nuova disciplina proposta, inoltre, in parte elimina e in parte riduce l’ambito di applicazione delle cause di non punibilità previste dalla normativa vigente. In sintesi viene mantenuta solo l’esclusione della punibilità per le valutazioni estimative di cui all’attuale quarto comma dell’articolo 2621 del codice civile – ai sensi del quale in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta – mentre viene soppressa la previsione di cui all’attuale terzo comma dell’articolo 2621, ai sensi della quale la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. Ancora più incisivo – da questo punto di vista – il già ricordato intervento proposto sull’articolo 2622 del codice civile dove – con l’abrogazione degli attuali commi settimo e ottavo dello stesso – vengono eliminate tutte le attuali cause di esclusione della punibilità al presumibile fine di assicurare, con riferimento alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, un grado di tutela penale ulteriormente rafforzato.
Con riferimento alle modifiche apportate dagli articoli 7 e 8 del testo in esame agli articoli 2621 e 2622 del codice civile si rileva come rimanga immutata dal punto vista letterale la formulazione del quinto comma dell’articolo 2621, mentre il nono comma dell’articolo 2622 – che, come accennato, nel testo vigente fa riferimento ai casi di cui ai commi settimo e ottavo dell’articolo medesimo – viene modificato sostituendo tale riferimento con quello ai casi di cui ai commi primo e terzo (sempre dello stesso articolo 2622). Va peraltro osservato come, in seguito alle altre modifiche apportate agli articoli 2621 e 2622, la portata dei citati commi quinto e nono verrebbe a modificarsi in modo sostanziale. Infatti, nelle vigenti previsioni. i commi predetti stabiliscono sanzioni pecuniarie amministrative la cui applicabilità è limitata ai casi in cui risulta esclusa la rilevanza penale delle condotte considerate. Diversamente, nell’assetto normativo conseguente alle modifiche proposte dal testo in esame, le predette sanzioni amministrative – fatta eccezione per il rinvio al comma quarto dell’articolo 2621 contenuto nel comma quinto dell’articolo medesimo – si riferirebbero a condotte che avrebbero rilevanza penale; in ordine a tali condotte troverebbero quindi applicazione sia le sanzioni penali sia le richiamate sanzioni amministrative. In proposito potrebbe rilevarsi che tale soluzione normativa ha carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia rapporti fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, definiti a livello legislativo nel senso della alternatività fra queste due tipologie di sanzioni e della prevalenza – almeno tendenziale – della disposizione speciale in caso di sovrapposizione di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e disposizioni che prevedono sanzioni penali (si veda in tal senso l’articolo 9 della legge n. 689 del 1981, nonché – per la materia tributaria – l’articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000).
1) Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse
volte in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Fondamentale al riguardo è la sentenza n. 409 del 1989, secondo la quale “il principio d’uguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; … le valutazioni all’uopo necessarie rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza” (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Questa sentenza è richiamata nella sentenza n. 341 del 1994, in cui il principio di proporzione tra offesa e sanzione è collegato anche al principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nello stesso senso la sentenza n. 394 del 2006 ha rilevato come “gli «apprezzamenti in ordine alla “meritevolezza” ed al “bisogno di pena” – dunque sull’opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono …, per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio…, come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.”.
2) Una sommaria disamina della giurisprudenza anteriore alla legge n. 190 del 2012 parrebbe confermare – in punto di fatto – l’impostazione della relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 19 citato. Si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 3403 del 11-04-1997; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 11480 del 15-12-1997; Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 15742 del 03-04-2003; Cass. pen. Sez. VI, Sent. n. 8907 del 03-12-2007.
3) L’art 648 c.p. disciplina la ‘Ricettazione’ e così recita:
‘Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto’.
4) Le sentenze citate si riferiscono a richieste di estradizione avanzate dalle autorità giudiziarie di Svizzera e Stati Uniti. Il cosiddetto autoriciclaggio risulta penalmente sanzionato anche in altri Paesi come, ad esempio, la Spagna e la Francia. Si veda a tale proposito la Nota n. 39 – 28 novembre 2012 “Il reato di autoriciclaggio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, curata dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.
5) Al fine di mantenere al di fuori dell’ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti – in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società – si è fatto ricorso alla formula “in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,” quale connotato che deve necessariamente caratterizzare la condotta incriminata.
Cosa cambia con i nuovi emendamenti presentati dal Governo?
Le false comunicazioni sociali
Per effetto dell’emendamento proposto è rilevante l’aumento delle sanzioni di carattere penali con pene inasprite con modifiche all’art. 2621 c.c.; gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni.
La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Va rilevato che rispetto alla disciplina anteriore al D.Lgs. 61/2002 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali), c’è un aumento della pena detentiva; il decreto legislativo , infatti, prevedeva una reclusione da uno a cinque anni.
Il reato, per effetto delle modifiche proposte, è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di società che non superano i limiti indicati, dal secondo comma , dell’articolo 1, della Legge fallimentare.
Le soglie di punibilità
L’emendamento governativo modifica anche l’art. 2622 del codice civile; con riferimento alle false comunicazioni sociali, il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato un’alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto, non superiore all’1 per cento.
Tuttavia, se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d’ufficio.
Se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa da tre mesi a tre anni.
Le false comunicazioni sociali nelle società quotate Importanti modifiche sono effettuate, dalle proposte di modifiche governative, all’articolo 2622 del c.c., relativamente alle società quotate: per le società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico , c’è un rilevante aumento delle sanzioni per i dirigenti e gli organi sociali con la punizione della reclusione che passa dall’attuale “da uno a quattro anni” a quella da “tre a otto anni”.
Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà.
Sanzioni amministrative per i nuovi reati societari
Le proposte di modifica del Governo, al ddl 19 “Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio” vanno a colpire anche il D.Lgs. n.231/2001, con un aumento delle sanzioni per i nuovi reati previsti dall’art. 25-ter, del citato decreto legislativo.
Due, in particolare, sono le modifiche che si propongono:
per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria è da duecento a quattrocento quote;
per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote.
Reati Societari. Emendamenti al testo unificato . Senato Commissione Giustizia.
07.01.2015
Senato 2ª Commissione - Giustizia
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER
I DISEGNI DI LEGGE
NN. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868
Art. 1
1.10000
Il Governo
Sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) all'articolo 319 le parole: ''da quattro a otto anni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''da sei a dieci anni''».
Art. 3
3.0.1001 (testo 2)
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso)
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la
promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui
all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare
gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel
primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al
primo comma''».
3.0.1002 (testo 2)
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso)
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da
quattro a diceci anni" sono sostituite dalle seguenti: " reclusione da sette a docdici
anni"».
3.0.1003 (testo 2)
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso)
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole " mediante le
modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis"».
3.0.10000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)
1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: ''da sette a dodici anni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''da dieci a quindici anni'';
b) al secondo comma, le parole: ''da nove a quattordici anni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''da dodici a diciotto anni'';
c) al quarto comma, le parole: ''da nove a quindici anni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''da dodici a venti anni''; e le parole: ''da dodici a ventiquattro anni'' sono
sostituite dalla seguenti: ''da quindici a ventisei anni''».
3.0.10001
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)
1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma terzo
è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Quando esercita l'azione penale per i delitti di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente
dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione.''».
Art. 5
5.10000
Il Governo
Sopprimere l'articolo.
Art. 6
6.10000
Il Governo
Sopprimere l'articolo.
6.0.10000
Il Governo
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente
comma:
''1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319- quater e 322-bis l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è
subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato''».
Art. 7
7.10000
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)
1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
''2621. – (False comunicazioni sociali). – 1. Gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza,
espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione
da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o
omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli
altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di società che non superano i
limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
3. Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una
alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una
variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore
al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
4. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai
creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino
alla metà e si procede comunque d'ufficio.
5. Nel caso previsto dal comma secondo, se la querela non è stata presentata
o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote
e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco nonché da ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre
mesi a tre anni.''».
Art. 8
8.10000
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali nelle società con
titoli quotati o diffusi)
1. L'art. 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
''2622. – (False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra
il pubblico in misura rilevante). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali al fine di conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa
dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti
con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche
se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
2. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai
creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino
alla metà.''».
8.0.10000
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione
ai reati societari)
1. All'articolo 25-terdel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:'';
b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
''a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;'';
c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
''b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;'';
d) la lettera c) del comma 1 è soppressa».
8.0.10001
Il Governo
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Procedimento di esecuzione)
1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, il periodo da ''L'interessato che ne fa richiesta'' a ''salvo che il
giudice ritenga di disporre la traduzione'' sono soppresse;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
''4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi
previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie,
con le modalità ivi previste.
4-ter. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla
circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza,
attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo
146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi
tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno
dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque
necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione.''».
Art. 8-ter.
(Partecipazione al dibattimento a distanza)
1. All'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di
attuazione, coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di
procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di
detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché
nell'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, la partecipazione al
dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:
a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche
penitenziaria;
b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a
distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di
evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto
che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti
processi presso diverse sedi giudiziarie.''».
8.0.10002
Il Governo
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Competenza territoriale)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il
seguente:
''Art. 5-bis.
(Questioni concernenti la competenza per territorio)
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non
proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere
rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.
2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti
all'organo proponente.
3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta
non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai
sensi dell'articolo 5.''.
2. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
''2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la
restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era
incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.
2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche
qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal
questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi
di appello.'';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di
confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono
esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore
generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di
appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua
presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo,
altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di
prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.'';
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della
Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono
raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del
procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso
la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel
predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore
della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con
facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli
e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.''.
Art. 8-ter.
(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)
1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
parole ''I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente
o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,'' sono sostituite dalle seguenti: ''I
soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di
interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere''.
Art. 8-quater.
(Registri delle misure di prevenzione)
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1:
a) al secondo periodo sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure
della Repubblica»;
2) dopo le parole «titolari del potere di proposta» sono aggiunte le
seguenti: « Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione
ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;
b) al terzo periodo sono apportate le seguenti modifiche:
1) la parola «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale»;
2) dopo le parole « della proposta di misura personale e patrimoniale da
presentare al tribunale competente» sono inserite le seguenti: «, allegandone
copia».
Art. 8-quinquies.
(Sequestro e confisca)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole ''nei cui confronti è iniziato il procedimento'' sono
sostituite dalle seguenti: '', nei cui confronti è stata presentata la proposta,'';
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole ''misura di prevenzione'' è inserita la seguente:
''patrimoniale'';
2) dopo le parole ''o quando'' sono inserite le seguenti: '', nel corso del
procedimento,'';
3) dopo la parola ''indirettamente.'' sono inserite le seguenti: ''Il tribunale
ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici
registri.''.
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole ''costituiscano il reimpiego.'' sono aggiunte le
seguenti: ''In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei
beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale.'';
b) al comma 2 dopo le parole ''direttamente o indirettamente'' sono aggiunte
le seguenti: '', nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione
dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2.''.
3. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal
seguente:
''Art. 25. – (Sequestro e confisca per equivalente).- 1. Dopo la presentazione
della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo
20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche
ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e
la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza
dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18,
commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il
procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal
proposto.''.
Art. 8-sexies.
(Amministrazione e controllo giudiziario
di attività economiche ed aziende)
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal
seguente:
«Art. 34. – (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività
economiche e delle aziende). 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui
all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa,
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività
economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone
nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione
personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte
a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione
patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di
prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, dispone l'amministrazione
giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al
primo comma dell'articolo 17.
2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non
superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, a richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata
applicata.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice
delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai
titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese
esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità
stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività
d'impresa.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con
l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto
dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della
misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il
provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione
di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del
sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed
eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo
34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di
agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di
consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I.
Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di
confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui
al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al
comma 6, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 17 possono richiedere al tribunale
di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal
presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a
norma del comma 3.''.
2. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito
il seguente:
''Art. 34 bis. – (Controllo giudiziario delle aziende). 1. Quando l'agevolazione
prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale
dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle
aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si
possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne
l'attività.
2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a
un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
può:
a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o
l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al
questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del
luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede
legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione
o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore
non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione
al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto
obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale
riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al
giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale
stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e
può imporre: 1) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione
sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione,
direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza
l'autorizzazione da parte del giudice delegato; 2) di adempiere ai doveri informativi di
cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario; 3)
di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di
finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; 4) l'obbligo di adottare ed
efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter
del d.lgs. 231/2001; 5) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a
prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento
mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma
precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad
accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi
professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire
informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga
accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui
al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria
dell'impresa.
5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può
proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal
deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'art. 127 codice di procedura
penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove
nominato, il commissario giudiziario.''.
Art. 8-septies.
(Trattazione prioritaria ed esclusiva.
Individuazione dei termini di deposito)
1. Dopo il Capo V del Titolo II, Libro I, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, è inserito il seguente capo:
''Capo VI
TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO
Art. 34-ter.
(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)
1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti
dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti
organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei
procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono
tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della
magistratura.
Con cadenza annuale il dirigente dell'Ufficio comunica al Ministero della
Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti sulla base delle indicazioni del
Consiglio superiore della Magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei
provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata
e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di
comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla
trattazione di cui al comma 1.''.
2. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
''2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di
prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il
procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano
in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una
copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per
quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari.''.
3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il
seguente:
''Art. 7-bis.
(Termine di redazione del provvedimento)
1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla
conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed
in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non
superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con
eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo
154 delle norme di attuazione del citato codice.''.
Art. 8-octies.
(Disposizioni in materia di amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 35, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni
immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli
incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati,
definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno
per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono,
altresì, stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare
complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da
amministrare determinano il divieto di cumulo.
2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti
nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende
sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro
incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.»;
b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario
cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e
all'approvazione del rendiconto di gestione.»;
c) all'articolo 38:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia
propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore
utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le
modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis.»;
2) al comma 3 dopo le parole «altri soggetti qualificati,» sono inserite le
seguenti: «individuati e»;
3) i commi 4 e 6 sono soppressi;
4) al comma 7, le parole ''ai sensi del comma 3'' sono sostituite dalle
seguenti: ''ai sensi del comma 3 e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo
comma 3''.
Art. 8-novies.
(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)
1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito
il seguente:
''Art. 41- bis – (Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). – 1.
Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni individuate dall'articolo
48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro
più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate
aventi il compito di:
a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli
occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario sulla base delle direttive impartite
dal giudice delegato e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e
della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le
aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari
coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle
disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze
del procedimento di confisca;
e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate
dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo
delegato, è composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e
individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di
supporto di cui all'articolo 112;
b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta
regionale;
c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato,
ogni quattro mesi, dalle medesime, secondo criteri di rotazione;
d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime
secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;
f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3,
lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli
enti locali e della camera di commercio la partecipazione al Tavolo.
4. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso
spese per la partecipazione ai lavori.''.
Art. 8-decies.
(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)
1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole ''o sociali'' sono inserite le seguenti
''ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali'';
b) al quarto periodo, dopo le parole ''della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni'' sono inserite le seguenti: ''e ad altre tipologie di
cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della
mancanza di lucro'';
c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: ''La destinazione dei beni è
soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità
sul sito dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia
revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto
assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.''».
8.0.10003
Il Governo
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del
Codice antimafia)
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater I,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico,
600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, primo
comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto
comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle
altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche
per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità
a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non
può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.'';
b) i commi 2, 2-bis sono soppressi;
c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole ''Nel caso previsto dal comma 2'' sono sostituite dalle
seguenti: ''Nei casi previsti dal comma 1'';
2) le parole ''al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''allo stesso
comma'';
3) dopo le parole ''altre utilità'' e prima delle parole ''per un valore
equivalente'' sono inserite le seguenti: ''di legittima provenienza'';
d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono soppressi;
e) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole ''Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati'' sono inserite le seguenti: ''nonché
quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro'';
2) le parole ''da 1 a 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 e 2-ter'';
3) le parole '', nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale'' sono soppresse;
4) dopo le parole ''sino al provvedimento conclusivo dell'udienza
preliminare'' sono inserite le seguenti: ''ovvero, ove questa non sia prevista, sino
all'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio
immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi
dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale,'';
5) le parole ''tale provvedimento'' sono sostituite dalle seguenti ''tali
provvedimenti'';
f) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
''4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di
diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti
avere la disponibilità a qualsiasi titolo.''.
Art. 8-ter
(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o
morte del condannato)
1.All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-quinquies sono
aggiunti i seguenti:
«4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma
2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di
giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per
prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca,
previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
4-septies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la
confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento
inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei
confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.».
Art. 8-quater.
(Istituzione della ''Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie'')
1. La Repubblica riconosce il 21 marzo, come ''Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie''.
2. La ''Giornata'' di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della ''Giornata'' di cui al comma 1 sono organizzate, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale,
presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni,
iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani
generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli
avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle
politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di
collaborazione e partecipazione delle forze dell'ordine, della magistratura, delle
istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia.
Art. 8-quinquies.
(Permessi straordinari di lavoro)
1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani,
nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di ''testimone della
memoria storica'' al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi
straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento
ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza
in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio
nazionale. I permessi di cui al presente articolo sono concessi, fatte salve le
esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:
a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici
all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di
ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno
contro le mafie e il terrorismo;
c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e
dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazione e
degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero
dell'istruzione.
2. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono
stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 8-sexies.
(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone
offese, informate sui fatti e testimoni)
Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, le
parole ''e 13, comma 5,'' sono sostituite dalle seguenti: '', 13, comma 5, e 15''.
Art. 8-septies.
(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)
1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
''4-ter. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di
condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti
dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto
deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.'';
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
''c-quater) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o
dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti,
desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali
risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad
organizzazioni criminali di tipo mafioso.''».